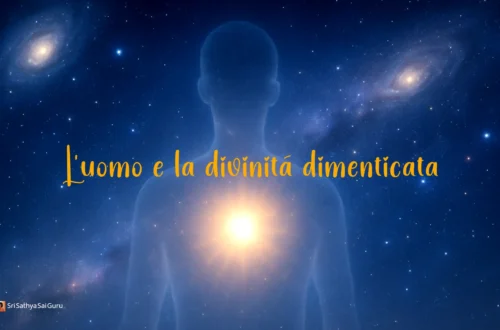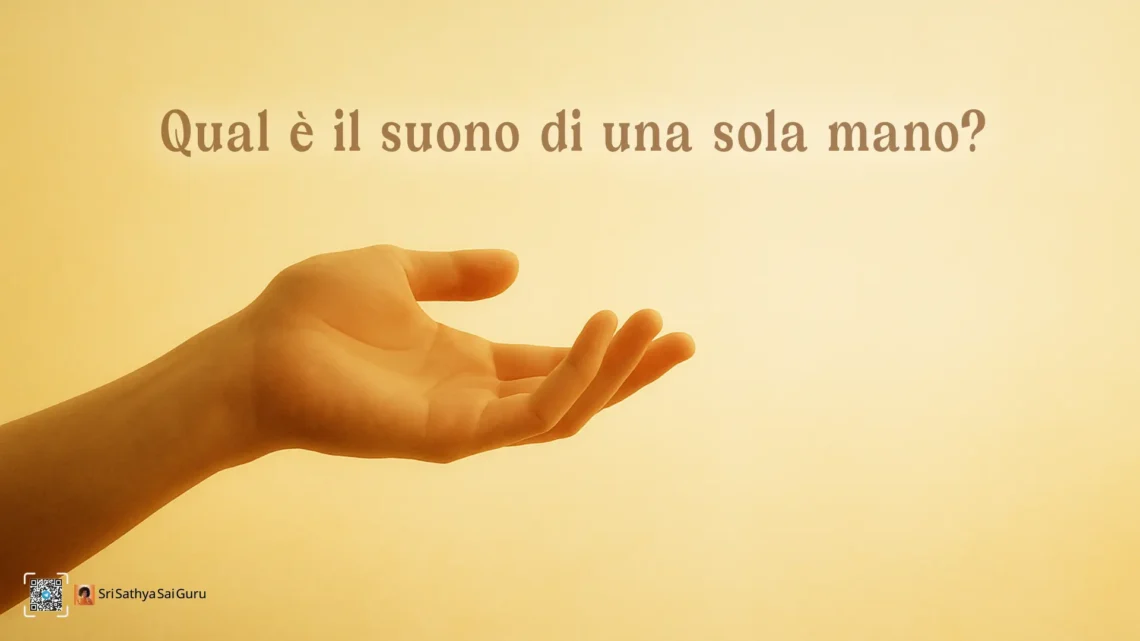
Qual è il suono di una sola mano?
Un giorno un maestro Zen radunò i suoi discepoli intorno a sé. Quindi, batté una volta le mani. La loro attenzione si fece più vigile.
Dopo alcuni minuti di silenzio assoluto, i discepoli iniziarono a guardarsi l’un l’altro. Nessuno comprendeva perché il maestro restasse immobile e in assorto silenzio. Non s’accorsero che la loro fretta di giungere ad una soluzione li stava ingannando.
Una decina di minuti più tardi, cogliendo tutti alla sprovvista, il maestro aprì gli occhi e rivolgendosi al più giovane di loro, un ragazzino di circa dieci anni, chiese: “Qual è il suono di una sola mano?“
Questa domanda è un famoso koan attribuito al maestro Hakuin Ekaku (XVIII secolo). Lo si trova “ambientato” in moltissime storielle Zen. Quella qui esposta è una di quelle tante.
Il termine koan, che in giapponese significa letteralmente “caso pubblico“, indica un racconto, o breve dialogo, paradossale. È una peculiarità del Buddhismo Zen; viene impiegato come strumento di insegnamento e meditazione.
Il koan non esprime un concetto logico convenzionale, ma punta a spezzare i meccanismi abituali del pensiero – il formale e la categorizzazione mentale – in favore di una esperienza diretta della verità. Conduce il praticante ad una comprensione intuitiva della Realtà, detta satori.
I satori possono manifestarsi in molte forme e gradi; sono considerati piccole “illuminazioni“, risvegli improvvisi – passi verso la piena realizzazione spirituale. Queste esperienze preparano progressivamente il terreno per l’illuminazione piena e stabile, spesso chiamata kenshō, realizzare la propria vera natura.
Non si giunge al kenshō senza passare per i satori, ovvero senza la graduale comprensione che la separazione e la dualità sono un’illusione.
Per affrontare un koan ci sono due passi conseguenziali: quello analitico, o intellettuale, e quello esperienziale, o meditativo. Il primo, presto o tardi, deve sfociare nel secondo. Pertanto, “consequenziali” assume che il primo passo possa essere stato assolto anche in vite passate.
Chi affronta la storiella qui presentata con mente logica cercherà di capire il significato della domanda. Potrebbe riflettere così: una sola mano non può produrre un suono nel senso comune, quindi forse vuole farci comprendere che il suono è un’illusione della dualità. Forse “una mano” rappresenta l’unità, e il “suono” rappresenta la manifestazione del mondo fenomenico. Il koan, di conseguenza, alluderebbe al rapporto tra l’Uno e i molti.
Oppure, la risposta potrebbe essere “il silenzio“, poiché il suono di una sola mano è il suono del silenzio. Infatti, il maestro resta immobile, in silenzio, lasciando i discepoli nell’agitazione, movimento.
Questo tipo di ragionamento può essere stimolante sul piano filosofico ed eruditivo, però rimane confinato nell’ambito concettuale: non porta all’esperienza diretta a cui lo Zen mira. Va trasceso.
Trascendere significa superare il confine del filosofico/concettuale per affronta la storia in modo esperienziale, ovvero, non per ricavare una risposta logica, bensì per andare oltre, ricavare una esperienza. Quindi, si siede in meditazione, zazen, respira e lascia che la domanda “Qual è il suono di una sola mano?” diventi viva dentro di sé.
Non cerca parole, né immagini, né spiegazioni. Si concentra sul koan fino a che ogni tentativo di comprendere svanisce. Ad un certo punto la mente smette di analizzare e quello che rimane è una consapevolezza pura, non formale, non duale. La domanda e colui che la pone, sé stessi, non sono più separati. In quell’istante, il “suono di una sola mano” si manifesta non come concetto, bensì come esperienza immediata.
La storiella, per indirizzare l’interessato a questa esperienza, offre un importante indizio: la domanda è posta al discepolo più giovane, colui la cui intelligenza non è invischiata negli schemi mondani. Sembra quasi dire: “Lasciate che i bambini vengano a Me“.