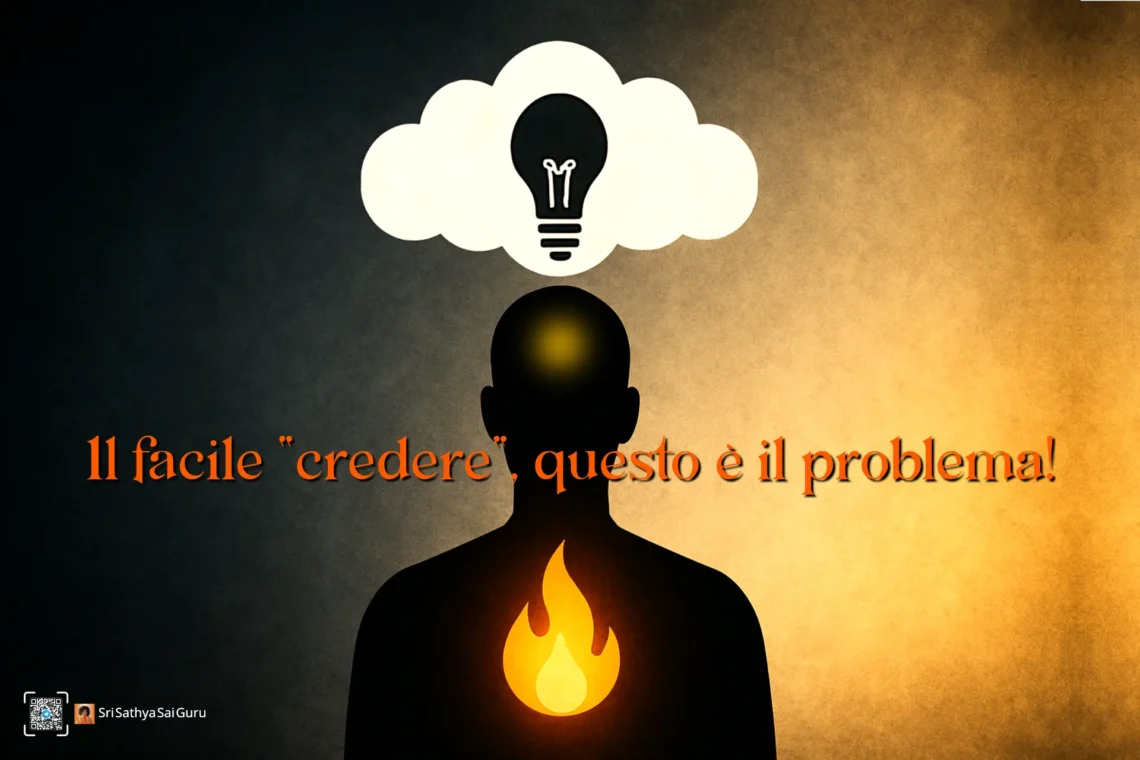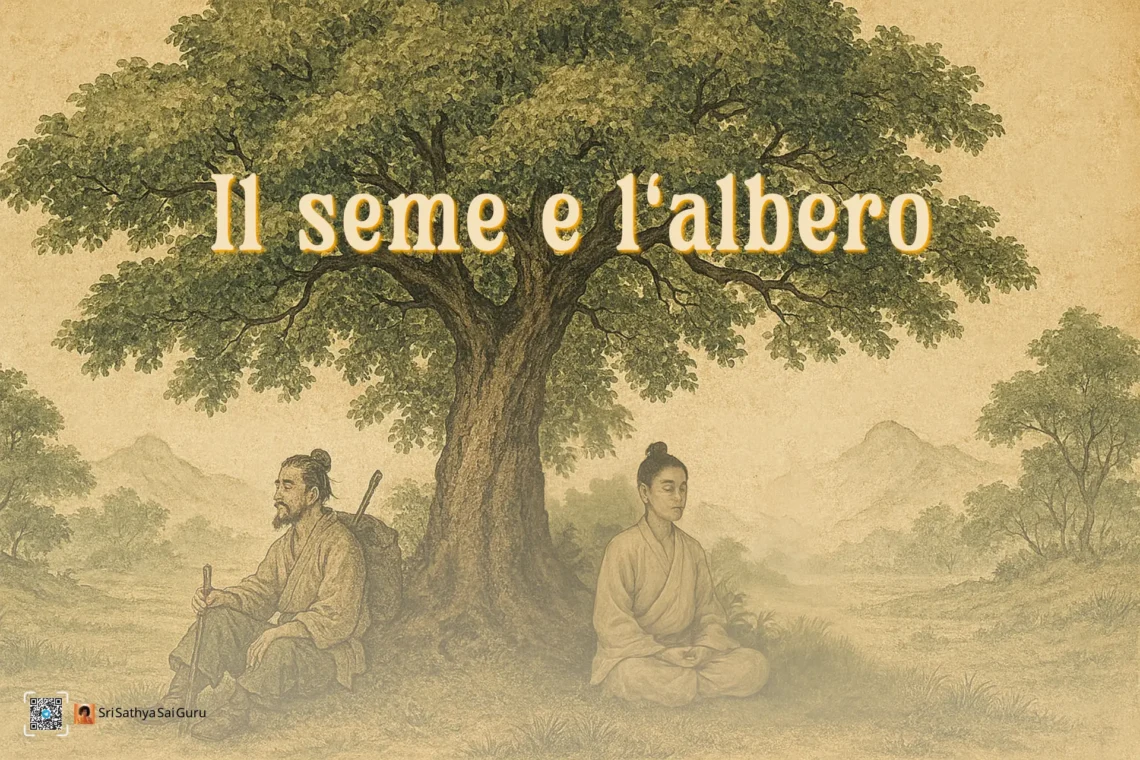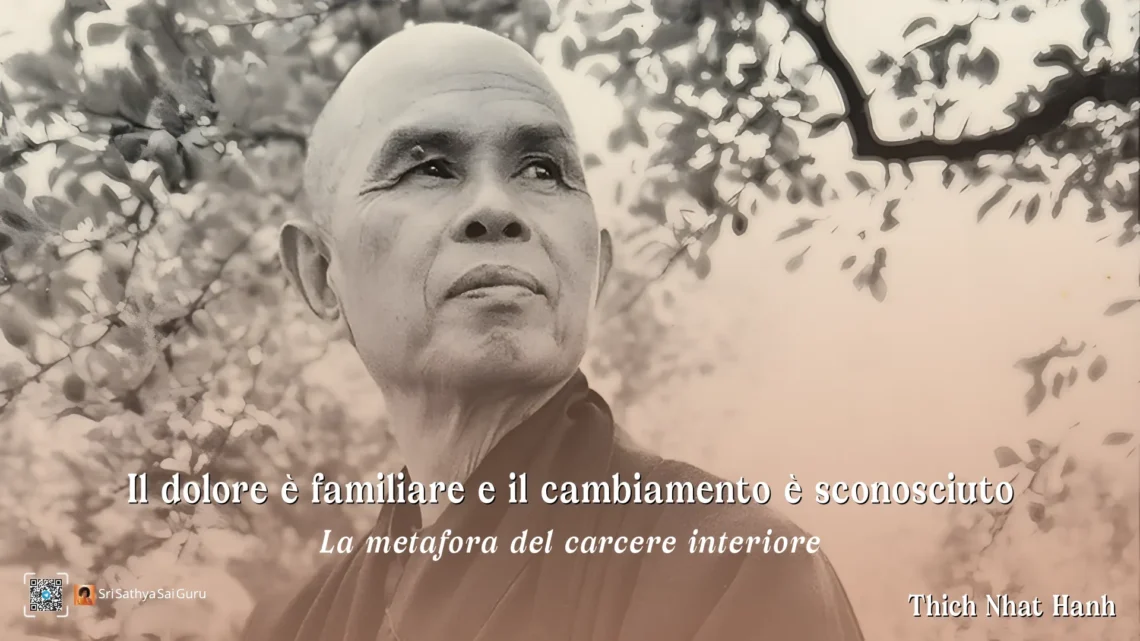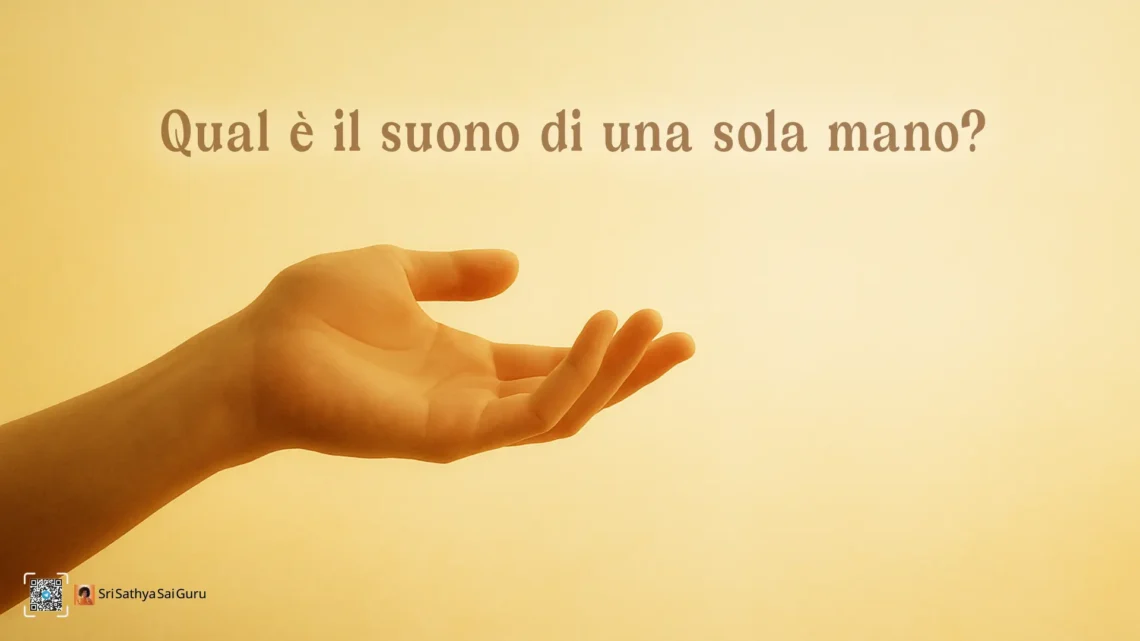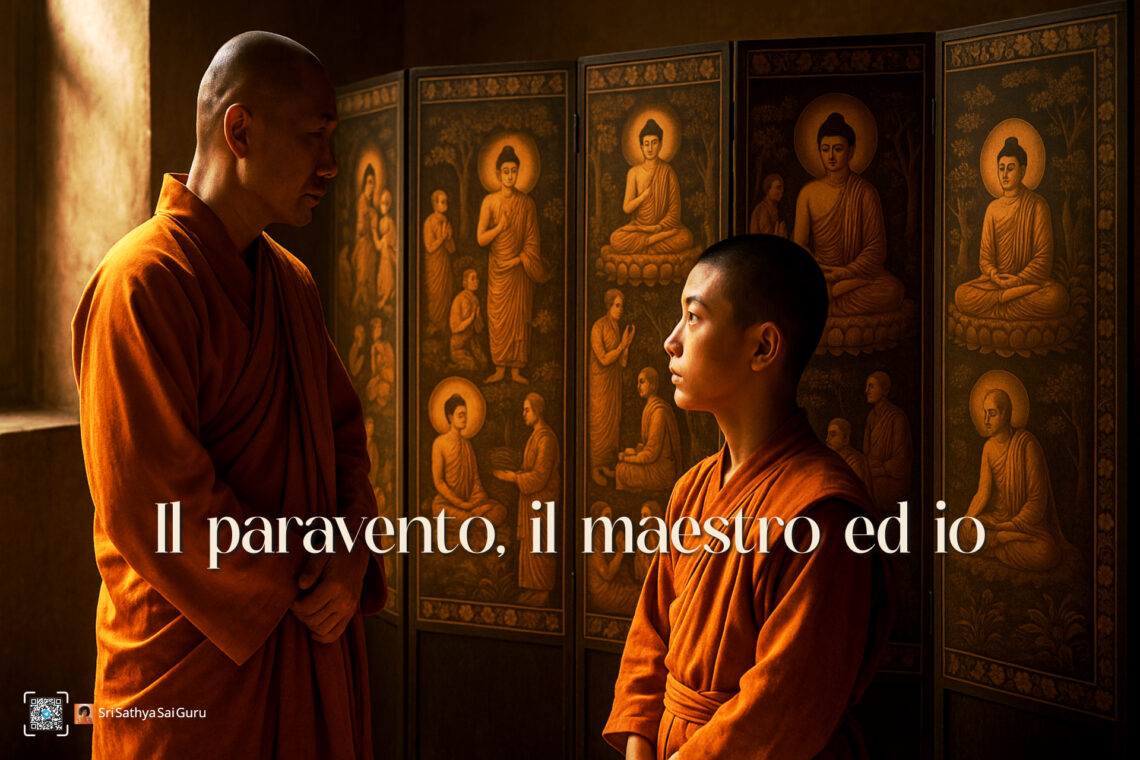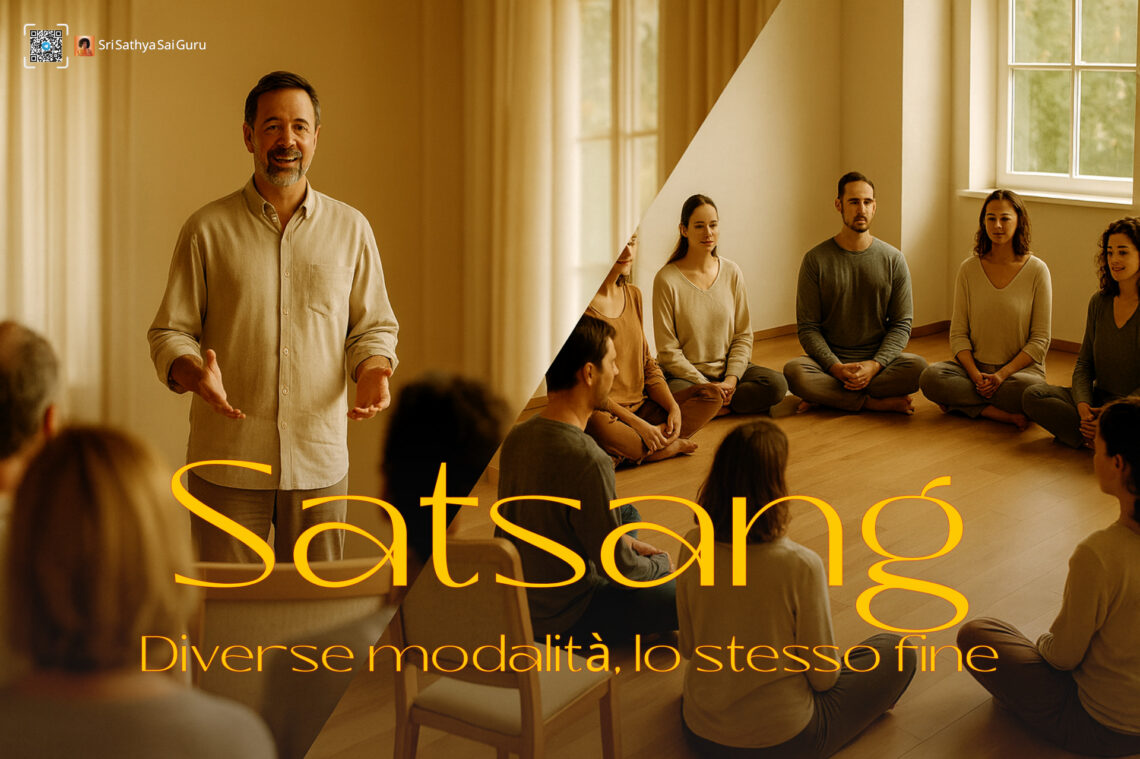-
Oltre al Dio pensato
È difficile per la maggior parte delle persone accettare che sia Dio a svanire e non l’uomo. Per alcuni, questa affermazione potrebbe costituire una vera e propria eresia, tanto da non prenderla nemmeno come ipotesi plausibile, una teoria da verificare.
Costoro dovrebbero fermarsi un momento ad indagare da dove derivi questa riluttanza. Scoprirebbero, probabilmente, che proviene da un sapere acquisito esteriormente, accreditato da fonti esterne assunte come autorevoli, accettate come verità e non come indicazioni per una individuale conquista interiore.
In ambito spirituale, il ricercatore deve essere conscio che tutti i testi sacri sono solamente indicazioni utili al “viaggio” interiore. La Meta è dentro, non esterna a sé. Persino l’Avatar non pretende d’essere creduto sulla parola, se non per quel minimo indispensabile ad dare corso a quella pratica che porta alla individuale esperienza. Infatti, è l’esperienza che annulla la comune necessità di credere. È lei che porta il ricercatore oltre alla mera informazione “tu sei Dio“.
In mancanza di tale fondamentale condizione, la diretta esperienza, quello a cui normalmente si tende a credere si ferma a livello concettuale, coadiuvato, a volte, da emozioni e inconsce necessità psicologiche. Nulla va oltre al mentale; tali credenze sono come nuvole nel cielo: si contraggono, si dilatano o si disperdono restando nella “troposfera“, il livello più basso dell’atmosfera, metaforicamente la mente.
Questi sono i limiti del Dio concettuale, il Dio che facciamo vivere nel nostro pensiero. Quando il pensiero svanisce, svanisce anche quel Dio che vi era contenuto. Quando il pensiero inizia a scricchiolare, ecco sorgere la “crisi“. Si inizia a dubitare di Dio, o più correttamente, a dubitare del proprio pensiero, del proprio contenitore. Questo accade perché si cerca di “credere in Dio“, anziché “conoscere Dio“.
Va compreso che Dio non può essere pensato, poiché il pensiero crea una distinzione tra soggetto e oggetto. Tale distinzioni, o separazione, non permette di cogliere quello che è il Soggetto per eccellenza, Dio.
Non si deve cercare Dio nei cieli delle idee acquisite, bensì nella terra fertile del silenzio interiore, dove il pensiero tace e l’Essenza si rivela.
Si deve iniziare ad esplorare come la propria tendenza a concettualizzare Dio ne riduca la portata, come nelle difficoltà personali e collettive i costrutti mentali su Dio possano vacillare, ma soprattutto, perché si confonde il pensiero teologico con l’esperienza divina.
Nella seconda delle sue 31 considerazioni, contenute nel suo libro I custodi dell’eternità, Giancarlo Rosati dichiara:
Comunemente si pensa che l’uomo muoia e che Dio sopravviva alla sparizione dell’umanità. Il concetto è falso: è vero il contrario. Noi esistiamo e continueremo ad esistere in quanto riflessi dell’Assoluto, mentre il Dio teologico/religioso che noi abbiamo inventato muore con l’individuo fisico. Essendo frutto dell’immaginazione, quando gli individui spariranno dalla faccia della terra – diceva Sai Baba e lo ribadiva Nisargadatta – Dio sparirà. Nisargadatta concludeva il suo pensiero dicendo: “Dio ha un destino che è legato al tempo. Quando Lui sparirà io ci sarò ancora perché io sono l’Eterno, l’Assoluto, e Lui era frutto del mio pensiero“.
In modo simile predicava il teologo e religioso tedesco del XIII/XIV secolo, Meister Eckhart:
L’uomo non deve accontentarsi di un Dio pensato, perché quando il pensiero svanisce, anche Dio svanisce. Piuttosto, dobbiamo possedere Dio nella Sua Essenza… In tutte le sue opere e in tutte le cose, l’uomo deve cogliere Dio nel modo più sublime possibile.
La coerenza lo portava a dichiarare di fronte ai fedeli: “Prego Dio che mi liberi da Dio“.
-
Il facile “credere”, questo è il problema!
Il termine “credere” è un termine interessante, spesso poco approfondito sia in ambito spirituale, che in qualsiasi altro aspetto della vita. Riflettere profondamente, attentamente e sinceramente su esso, il contesto su cui viene chiamato in causa e le relative implicazioni, risulterà davvero profittevole.
“Credere” significa “ritenere” vera una certa cosa. La maggior parte delle persone sviluppa le proprie idee, convinzioni ed azioni, e condiziona la propria vita su questo “ritenere“.
In senso semantico-pragmatico e non come distinzione rigidamente logica c’è dunque un’abissale differenza fra “credere“, o “ritenere“, ed “essere certo“. “Credere“, o “ritenere“, non equivale ad “essere certi“.
“Ritenere” avvia un processo, oppure ne postula o ne accompagna una passo, mentre “essere certo” ne constata il risultato finale. Più precisamente, il primo indica un atteggiamento cognitivo processuale e valutativo, il secondo esprime uno stato cognitivo stabilizzato e conclusivo.
“Ritenere” implica – sulla base degli elementi disponibili per dare avvio o svolgimento ad un percorso di giudizio, quali, indizi, argomenti, esperienze, credenze, ragionamenti, etc. – che si pervenga ad una conclusione che resta aperta alla revisione.
“Essere certo“, al contrario, dichiara che il processo valutativo è implicitamente dato per concluso e il risultato è assunto come definitivo e non problematico. Pertanto, ne afferma l’esito senza necessità di tematizzare il percorso.
Entrambi i termini, sebbene con grado diverso, sono soggettivi. Entrambi si relazionano al mondo fenomenico e riguardano lo stato psicologico dell’individuo, non la verità oggettiva di un fatto in sé. Quindi, non sono consequenziali: non si parte sempre dal “ritenere” per arrivare all'”essere certo“. Spesso si “ritiene” senza mai giungere alla “certezza“, o si “è certi“, per fede o pregiudizio, saltando un processo razionale o esperienziale. La loro differenza sta nel grado di convinzione e fondatezza. “Ritenere” è certamente più aperto al dubbio rispetto ad “essere certo“. Tuttavia, è pur vero che l'”essere certo“, a volte, è dichiarato da individui incapaci di gestire e risolvere i dubbi, rendendolo, di conseguenza, un raggiungimento totalmente fittizio.
In ambito spirituale, quando un devoto afferma “credo in Dio“, oppure “sono certo che Dio esiste“, sta sostanzialmente dichiarando, nel primo caso, qualcosa che ha carattere ipotetico, ossia, provvisorio o processuale; mentre nel secondo, un raggiungimento nella propria mente di una convinzione definitiva, non incline a rivisitazione. Entrambe le posizioni descrivono stati mentali soggettivi, non fasi di un percorso verso la Verità che sta oltre sia al soggettivo che all’oggettivo.
Nel mondo fenomenico il termine “Dio” è progressivamente una parola, un’idea e un concetto prodotti dall’uomo; una sua invenzione per il suo diletto, o una parvenza di un qualcosa che percepisce, ma non comprende, da sfruttare per la propria elevazione, per la via del suo ritorno. In quest’ultimo caso, strumento per il superamento della materialità, dell’intellettualizzazione e dell’astrazione.
Dio non produce le condizioni “ritenere” o “essere certo“. Dio è uno stato di coscienza, non un effetto partorito dalla mente. Pertanto, né la posizione del “credere/ritenere“, né la dichiarazione “sono certo” sostengono la piena Luce. Entrambe possono essere negate, poiché sorrette da basi deduttive o necessità psicologiche. Si dovrebbe notare la discrepanza tra “credere – essere certo“, le condizioni che favoriscono una fede ed un’adesione passive, e l’autenticità di quel raggiungimento che dissolve l’identificazione emotiva e il senso di appartenenza. In altre parole, ci si dovrebbe spingersi dal “vedere il fuoco o sentirne il suo calore“, posizioni esterne, al si “è Fuoco“; stato questo di cui non si può definire “interno“, poiché non esiste un secondo.
-
Il seme e l’albero
Nel viaggio che conduce alla meta naturale dell’uomo, la realizzazione del Sè, ci sono due costanti obiettivi: l’illuminazione vera e propria, quella che anticipa la Liberazione, e le piccole illuminazioni intermedie, ossia piccole liberazioni. Questo concetto viene spesso metaforizzato con una scala, la cui interezza rappresenta l’elevazione del percorso spirituale verso il fine ultimo della vita, mentre i singoli pioli, o gradini, simboleggiano le piccole illuminazioni. Le storielle zen si prefiggono di favorire tali piccole illuminazioni, precursori di quella finale.
Le storielle zen, non vanno paragonate alle brevi storielle, le Chinna Katha, raccontate da Sri Sathya Sai Baba.
In linea generale, le Chinna Katha sono racconti a carattere pedagogico, finalizzate a comprendere un principio morale, etico o interiore attraverso un episodio semplice. Le storielle zen, koan o aneddoti di maestri zen, sono spesso paradossali o aperte, destinate a far superare la logica ordinaria, provocando, di conseguenza, un’intuizione immediata, una piccola illuminazione, o satori. Il significato della storiella in sé non viene esplicitamente espresso.
Sempre il linea generale si potrebbe dire che le prime sono propedeutiche alla condizione richiesta dalle seconde. Le Chinna Katha instradano l’individuo alla riflessione, a renderlo pronto a cogliere quello che ha sempre avuto davanti agli occhi, pur senza rendersene conto, poiché limitato dalla logica mondana. Lo zen tenta di indurre quello che si chiama lo shock illuminativo, puntano a scardinare i concetti e sospendendo il giudizio.
Il maestoso albero, le cui fronde donano frescura e riposo al viandante, nasce da un piccolo seme. Oh uomo, siediti ai piedi dell’albero e realizza il seme!
La prima parte di questo koan descrive un fatto naturale, semplice e incontrovertibile. Il maestoso albero imponente, che offre riparo e conforto, ha un’origine umilissima: un piccolo seme. Chiunque sa che l’albero nasce da un seme. Questa è la logica formale: il velo da squarciare che tutti abbiamo davanti agli occhi.
La seconda parte è l’istruzione, il cuore del koan. Il maestro si rivolge direttamente al discepolo, di riflesso anche a noi, e lo invita ad un’azione paradossale: sedersi sotto l’albero per “realizzare il seme“, non per godere solo della frescura e dell’ombra, ossia i “frutti” dell’albero.
La scena nel suo complesso ci comunica anche qualcos’altro di importante: in entrambi i casi – rappresentati dal viandante, o mondo fenomenico, e dal meditante, o cammino spirituale – si deve essere nei pressi dell’albero, ovvero frequentare il giusto ambiente, o atmosfera, che induca il viandante a diventare meditante, e il meditante a raggiungere lo scopo.
L’albero simboleggia quella zona in cui l’aderenza alla morale, all’etica e ai Valori Umani favoriranno nell’uomo che li addotta a trasmutarsi in un ricercatore e a superare anche tale stadio.
Un altro insegnamento implicito è relativa al culto e alla ritualità. Questi non devono essere considerati il fine, ma solo i mezzi necessari a provocare la trasmutazione, l’avanzamento spirituale. In altri termini, la riduzione degli strati che velano la propria vera natura.
In tutto questo, dove trova posto il Maestro?
Il Maestro non rientra nella scena. Egli è la voce fuori campo. Egli è al di là della mondanità e della strada atta a trascenderla. Egli è il richiamo della Meta. È per tale motivo che non si diventa mai davvero Uno con il Maestro: dopo essersi identificati con Lui, abbandonando l’individualità si è una cosa sola con Lui. L’onda emersa dall’Oceano si riimmerge in esso. L’individualità è pura illusione. Nulla si è davvero mosso. Il seme e l’albero sono mutevoli, quindi apparenti. Nel silenzio interiore, messa da parte la mente, si lascerà affiorare il principio che si cela dietro la loro apparenza. -
Il dolore è familiare e il cambiamento è sconosciuto
La metafora del carcere interiore
Quello che segue è un passo riadattato del discorso che il monaco buddista (Buddhismo Thiến, lo Zen/Chán vietnamita) Thich Nhat Hanh (11/10/1926 – 21/01/2022) tenne al Maryland Correctional Institution, un istituto penitenziario, il 16 Ottobre 1999.
La metafora che propone merita particolare attenzione e una sincera riflessione, in quanto non è così facile scoprire il proprio carcere interiore, quello che ci “incarcera assai più di un carcere fisico.
Spesso si dice che se prendi un prigioniero e lo liberi dopo molti anni, lui non saprà come vivere da uomo libero. Potrebbe persino desiderare di tornare nella sua cella. La paura della libertà, la paura dell’ignoto, è così forte che preferisce la sofferenza che conosce. Noi tutti abbiamo un carcere interiore, e le sbarre di quella prigione sono le nostre paure, le nostre abitudini, le nostre percezioni erronee. Anche se la prigione ci causa dolore, è un dolore che conosciamo. L’ignoto al di fuori della prigione ci spaventa di più.
— Thich Nhat Hanh
Da Be Free Where You Are: A Talk Given At The Maryland Correctional Institute – Sii libero ovunque ti trovi: un discorso tenuto al Maryland Correctional Institute.
-
Qual è il suono di una sola mano?
Un giorno un maestro Zen radunò i suoi discepoli intorno a sé. Quindi, batté una volta le mani. La loro attenzione si fece più vigile.
Dopo alcuni minuti di silenzio assoluto, i discepoli iniziarono a guardarsi l’un l’altro. Nessuno comprendeva perché il maestro restasse immobile e in assorto silenzio. Non s’accorsero che la loro fretta di giungere ad una soluzione li stava ingannando.
Una decina di minuti più tardi, cogliendo tutti alla sprovvista, il maestro aprì gli occhi e rivolgendosi al più giovane di loro, un ragazzino di circa dieci anni, chiese: “Qual è il suono di una sola mano?“
Questa domanda è un famoso koan attribuito al maestro Hakuin Ekaku (XVIII secolo). Lo si trova “ambientato” in moltissime storielle Zen. Quella qui esposta è una di quelle tante.
Il termine koan, che in giapponese significa letteralmente “caso pubblico“, indica un racconto, o breve dialogo, paradossale. È una peculiarità del Buddhismo Zen; viene impiegato come strumento di insegnamento e meditazione.
Il koan non esprime un concetto logico convenzionale, ma punta a spezzare i meccanismi abituali del pensiero – il formale e la categorizzazione mentale – in favore di una esperienza diretta della verità. Conduce il praticante ad una comprensione intuitiva della Realtà, detta satori.
I satori possono manifestarsi in molte forme e gradi; sono considerati piccole “illuminazioni“, risvegli improvvisi – passi verso la piena realizzazione spirituale. Queste esperienze preparano progressivamente il terreno per l’illuminazione piena e stabile, spesso chiamata kenshō, realizzare la propria vera natura.
Non si giunge al kenshō senza passare per i satori, ovvero senza la graduale comprensione che la separazione e la dualità sono un’illusione.
Per affrontare un koan ci sono due passi conseguenziali: quello analitico, o intellettuale, e quello esperienziale, o meditativo. Il primo, presto o tardi, deve sfociare nel secondo. Pertanto, “consequenziali” assume che il primo passo possa essere stato assolto anche in vite passate.
Chi affronta la storiella qui presentata con mente logica cercherà di capire il significato della domanda. Potrebbe riflettere così: una sola mano non può produrre un suono nel senso comune, quindi forse vuole farci comprendere che il suono è un’illusione della dualità. Forse “una mano” rappresenta l’unità, e il “suono” rappresenta la manifestazione del mondo fenomenico. Il koan, di conseguenza, alluderebbe al rapporto tra l’Uno e i molti.
Oppure, la risposta potrebbe essere “il silenzio“, poiché il suono di una sola mano è il suono del silenzio. Infatti, il maestro resta immobile, in silenzio, lasciando i discepoli nell’agitazione, movimento.
Questo tipo di ragionamento può essere stimolante sul piano filosofico ed eruditivo, però rimane confinato nell’ambito concettuale: non porta all’esperienza diretta a cui lo Zen mira. Va trasceso.
Trascendere significa superare il confine del filosofico/concettuale per affronta la storia in modo esperienziale, ovvero, non per ricavare una risposta logica, bensì per andare oltre, ricavare una esperienza. Quindi, si siede in meditazione, zazen, respira e lascia che la domanda “Qual è il suono di una sola mano?” diventi viva dentro di sé.
Non cerca parole, né immagini, né spiegazioni. Si concentra sul koan fino a che ogni tentativo di comprendere svanisce. Ad un certo punto la mente smette di analizzare e quello che rimane è una consapevolezza pura, non formale, non duale. La domanda e colui che la pone, sé stessi, non sono più separati. In quell’istante, il “suono di una sola mano” si manifesta non come concetto, bensì come esperienza immediata.
La storiella, per indirizzare l’interessato a questa esperienza, offre un importante indizio: la domanda è posta al discepolo più giovane, colui la cui intelligenza non è invischiata negli schemi mondani. Sembra quasi dire: “Lasciate che i bambini vengano a Me“.
-
Il rotolo di pergamena sigillato
Da tempo sollecitava il suo maestro affinché gli rivelasse quale fosse il suo destino, ma lui sorrideva e passava oltre.
Un giorno, lo vide venirgli incontro con un rotolo di pergamena sigillato in mano.
“Questo contiene il tuo destino“, disse. “Ma non aprirlo ancora. Prima, vai nella pianura silenziosa e siediti. Quando avrai compreso il suono del vento tra i fili d’erba, allora potrai rompere il sigillo“.
Colmo di eccitazione, il discepolo viaggiò per giorni fino a raggiungere la vasta pianura. Si sedette e attese come da istruzioni impartite.
Dopo alcuni giorni passati in reverente ascolto, del solito fruscio iniziò ad apprezzarne le diverse sfumature. S’impegnò con maggiore rigore e così, dopo qualche tempo, riuscì persino a distinguere le infinite sfumature: un gemito lieve, un sospiro, un canto gioioso.
I mesi volarono. Assorto nel cosciente ascolto dimenticò il rotolo riposto nella sua bisaccia. Un giorno, all’improvviso, un suono emerse da un luogo profondo dentro di sé. Sembrava lo stesso identico suono che trasportava il vento. Lo ascoltò più attentamente e gli parve che fosse il vento a replicare questo genuino suono.
In quel preciso momento, finalmente, realizzò. Estrasse la pergamena, spezzò il sigillo con animo sereno, quasi ne conoscesse il contenuto. La pergamena si srotolò. Lui rise di pura gioia. Non conteneva una parola, né un segno. Era totalmente vuota, come la sua mente ora.
Aveva impiegato molti anni a leggere la mappa, ma scoprì qui e ora che il tesoro era stato sempre dentro di lui. Il dovere non era decifrare un enigma, bensì sedersi nella vallata interiore, ascoltare e arrivare a sé stessi. Il destino non era scritto da nessuna parte, se non nel battito del suo stesso cuore.
-
Il paravento, il maestro ed io
Il maestro mi mostrò il paravento che gli avevano donato.
Lo osservai attentamente. Era molto bello, decorato con le scene più significative della vita del Buddha. Stavo per esprimere il mio apprezzamento su quanto quelle immagini, così vivide, favorissero l’immedesimarsi sul Buddha e i Suoi Insegnamenti.
Ma il maestro mi anticipò, portando quel momento ad un alto livello.
Questo mi insegnò: “I pensieri sono come questo paravento. Non fermarti solo ad osservarlo, guarda cosa cela dietro. Il paravento serve a nascondere qualcosa. Il fatto di giudicarlo bello o brutto, ne è la prova: resti di qua! Questo è il metodo con cui la mente tenta di inibirti a oltrepassarla. I pensieri sono per gli uomini il paravento del proprio dolore. Finché non posi gli occhi su quello che sta dietro, resterai nella convinzione che sia dolore. Questa convinzione è sana finché stai di qua. Appena andrai di là scoprirai che l’inganno risiede di qua!“
-
Satsang: diverse modalità, lo stesso fine
Il termine satsang definisce un gruppo di persone che tramite il dialogo, l’ascolto, la riflessione e la meditazione si pongono come obiettivo il raggiungimento della Realtà, ovvero la Verità. Ne consegue che esistono diverse modalità per impostare un satsang. Tuttavia queste non devono alterarne la sua finalità.
In linea di massima e senza presunzione di esaustività, i satsang si possono tenere in due principali modalità, che per comodità definiremo: stile “conferenza” e stile “circolo di studio“. La scelta di una o dell’altra modalità è dettata da questioni operative, o specifiche esigenze. In ogni caso non alterano il loro obiettivo fondamentale, ovvero, sperimentare l’Unità del Sé.
Nella modalità stile “conferenza” la parola viene presa da una o da poche persone, mentre tutte le altre ascoltano. In alcuni casi, alla fine degli interventi, è possibile sottoporre delle domande di approfondimento, mentre in altri casi questo momento non è previsto o non è fattibile.
Nella modalità stile “Circoli di Studio” (CdS), invece, i partecipanti si dispongono in cerchio e di norma intervengono a turno rotatorio sul tema oggetto dell’incontro, esponendo le proprie riflessioni in modo sintetico, chiaro e il più distaccato possibile, ovvero in modo meno coinvolto possibile.
Gli incontri stile CdS possono essere attuati in due modalità, che per pura comodità definiamo: “formale” e “fraterna“
Nella modalità “formale” ogni partecipante interviene evitando di relazionarsi con gli altri. In sostanza ognuno da’ il suo contributo quando chiamato e raccoglie dal gruppo quanto necessita senza chiedere approfondimenti.
Nella modalità “fraterna“, invece, l’interazione con gli altri è auspicabile a patto che sia scevra da giudizi, prevaricazioni e contestazioni. Questa soluzione spinge il partecipante a mettersi in gioco in modo più profondo. Qui si cerca di toccare quell’aspetto unitario e solidale caratteristico dei gruppi affiatati, dei commilitoni, degli alpinisti in cordata. Questa soluzione fa emergere maggiormente la consapevolezza che il bene proprio, al pari del bene dell’altro, sono interdipendente in modo diretto e mutuo al bene comune. In questa modalità il dialogo è più enfatizzato rispetto a quella “formale“.
Questa pratica spirituale, indipendentemente dalla impostazioni stile “conferenza” o “CdS” e relative modalità, assicura matematici benefici ai suoi costanti aderenti che si approcciano praticando l’ascolto, la riflessione e la meditazione.
-
Concentrazione e meditazione
Si calcola che ogni giorno una persona elabori un susseguirsi di 60-80 mila pensieri di cui non è consapevole. In questa avidya, nasce, cresce e si diffonde la sofferenza.
Si può affermare che la vita senza la consapevolezza di averla vissuta equivale a vita “non vissuta“. Gli studiosi di scienze cognitive ci informano che sono parecchie le decine di migliaia di pensieri quotidiani che ospitiamo nella nostra mente senza rendercene conto; pensieri che, nonostante ignoriamo la qualità, concorrono a crearne di nuovi, che intervengono nei nostri ragionamenti, che sono presenti nelle nostre valutazioni e nelle nostre decisioni. Pensieri che, essendo noi all’oscuro di possedere e di interagire, non li relazioniamo con gli effetti che apportano, siano questi favorevoli o avversi. Per sottolineare la centralità della mente nella qualità della vita di una persona, riportiamo in fondo all’articolo il PdG del 26 Giugno 2022 di Bhagawan.
L’economista, psicologo ed informatico statunitense, nonché premio Turing e Nobel, Herbert Simon ci ha permesso, mediante una sua celebre analisi sull’informazione, di rivalutarla sia dalla prospettiva del fornitore, che di quella dell’utilizzatore.
Afferma il dr. Simon: “Ciò che l’informazione consuma è abbastanza ovvio: consuma l’attenzione dei suoi destinatari. Quindi una ricchezza di informazioni crea una povertà di attenzione ed un bisogno di distribuire quell’attenzione in modo efficiente tra la sovrabbondanza di fonti di informazioni che potrebbero consumarla“.
Tirando le somme: DISTRAZIONE = PERDITA DI TEMPO e SPRECO DI ENERGIE.L’unica strada percorribile per vivere la vita nella sua interezza è adottare un appropriato stile di vita che riorganizzi, almeno in un primo momento, le attuali abitudini e che favorisca la concentrazione. A tale fine, più in basso, si propongono 5 suggerimenti per ridurre le distrazioni, sette abitudini da abbandonare (possibilmente con estrema urgenza) e una abitudine da far crescere.
Il “qui ed ora” è la vita stessa. Il Buddha ci fornisce una indicazione per sperimentare quello che a parole non si può né spiegare, né completamente comprendere: “Il segreto della salute fisica e mentale non sta nel lamentarsi del passato o preoccuparsi del futuro, bensì nel vivere il momento presente con saggezza e serietà“.
La concentrazione non è un metodo di rilassamento, anche se utilizza il rilassamento per acquietare corpo e sensi. Per mezzo della concentrazione si arriva alla meditazione passando per la contemplazione, termine questo di cui si dovrebbe apprezzare il diverso significato fra Occidente ed Oriente.
Pertanto, è fondamentale che ognuno trovi da sé le motivazioni e i benefici, sia in ordine mondano che spirituale, sul perché dovrebbe praticare la meditazione con costanza quotidiana. Tale conquista lo renderà immune dalle dicerie altrui.
◼️ Pensiero del Giorno del 26 Giugno 2022
È la mente che forma o rovina una persona. Se è immersa nelle cose del mondo, conduce alla schiavitù; se tratta il mondo come temporaneo, allora con il distacco diventa libera e leggera.
Allenate la mente a non sentirsi attaccata alle cose che cambiano in meglio o in peggio. Non tenete davanti a voi gli orpelli della fama e delle ricchezze mondane; attirate la mente verso gioie durature che scaturiscono dalle sorgenti dentro di voi. Questo porterà grandi ricompense. La mente stessa diventerà quindi il guru, perché vi condurrà sempre più avanti una volta assaporate le dolcezze dell’ascolto, del ricapitolare e della meditazione costante e continuata.
È la mente che conferisce alla figura creata dal ceramista la Divinità che il devoto vede in essa; è la mente che riempie la stanza del santuario con la fragranza della santità.
— Discorso Divino del 24 Marzo 1958
◼️ RIDUZIONE DELLE DISTRAZIONI – suggerimenti
- Eliminare dalla propria area operativa tutte le fonti di distrazioni
Es: se si cucina, spegnere la TV – sconnettersi o silenziare i servizi social – non tenere riviste bagno – non usare troppi post-it – sulla scrivania che trovino posto solo lo stretto occorrente per quel specifico lavoro, etc. - Impegnarsi a svolgere un solo compito alla volta aumentando la consapevolezza del qui ed ora
Es: nei lavori ripetitivi non lasciare divagare la mente, soprattutto nel passato o nel futuro, o in altri lavori. - Pianificare delle pause per le distrazioni indomabili – l’obiettivo resta comunque quello di ridurle;
Es: abituiamo gradualmente la mente alla disciplina evitando di essere tragici. Concediamole alcuni svaghi a cui è abituata limitandole progressivamente il tempo e smorzando l’interesse. Non rendiamocela nemica, sarebbe un grosso errore. - Stabilire un’importanza e una tempistica su cosa ascoltare e guardare
Es: è risaputo che alcune musiche, come alcuni programmi, nella loro costate ossessività favoriscono stati d’ansia, irrequietezza e vizi. Altri, per mezzo del divertimento e del carisma, veicolano messaggi tendenziosi, poco rispettosi della propria individualità, falsi, indecenti, contrari alle leggi divine. Eliminarli senza alcuna titubanza. - Impegnarsi ad amare il silenzio – soprattutto interiore
È qui, superato l’iniziale imbarazzo psicologico, che si può ascoltare la Voce di Dio.
◼️ SETTE ABITUDINI DA ABBANDONARE
- Dubitare di sé stessi
- Pensiero negativo
- Dialogo negativo con sé stessi
- Compiacere gli altri
- Criticare gli altri
- Paura del fallimento o del successo
- Procrastinare
◼️ UNA ABITUDINE DA FAR CRESCERE
- Guardarsi dentro con amore e rispetto.
- Eliminare dalla propria area operativa tutte le fonti di distrazioni
-
Una cura in quattro rimedi
Iniziò a studiare filosofia da ragazzino. All’epoca, siamo nella Grecia del IV-III secolo a.C., il termine “filosofia” era pregno di un significato profondo, di un impegno verso sé stessi e la società, intesa come qualcosa che supera le barriere spazio-temporali. Oggi questo significato, questo senso di impegno-dovere, si è impoverito e decurtato. Non è più considerato essenziale. La filosofia oggi, salvo rare eccezioni, è un termine che si è svuotato del suo intrinseco valore.
Da allora ad oggi in comune resta solo il mero retaggio formale del termine: amore per la sapienza, o amore per la saggezza. Nel mezzo, secolo dopo secolo, il termine di derivazione greca (ϕιλοσοϕία) perse il suo tratto distintivo, rimpiazzandolo con surrogati che avallassero le varie ideologie che le impellenti contingenze politiche e militari partorivano nell’intento di assicurarsi i loro obiettivi economici e territoriali.
Non si può spiegare a parole l’anima di certi termine. Questa anima può essere intuita solamente frequentando chi vive in simbiosi con essa, chi e si prefigge di scoprirla senza risparmiarsi. Non ci sono alternative, che non siano, appunto, svilenti surrogati.
Epicuro, importante filosofo greco (341 a.C. – 270 a.C), iniziò a studiare filosofia e a viverla dall’età di 14 anni. A suo dire, lo scopo della vita è il raggiungimento della felicità, la quale si ottiene attraverso il piacere – definito come assenza di dolore fisico (aponia), o edonismo non sfrenato – e l’assenza di turbamento dell’anima (atarassia), ovvero, l’indifferente serenità del saggio che, raggiunto il dominio sulle proprie passioni, è imperturbabile di fronte alle vicende del mondo.
Epicuro classificò i desideri in tre categorie:
- naturali, come il cibo, l’acqua, e un rifugio;
- naturali ma non necessari, come il lusso o i piaceri raffinati;
- non naturali e non necessari, come il desiderio di potere o ricchezza.
Pertanto, il piacere – quale mezzo per raggiungere la felicità, scopo della vita – non consiste nell’accumulo di beni materiali o nel soddisfacimento illimitato dei desideri, bensì nella moderazione e nella saggezza.
Nella sua visione, la filosofia è uno strumento per liberare l’uomo dalle paure, come quella della morte e degli Dèi. Questo lo portò a suggerire una “cura in quattro rimedi“, il famoso tetrafarmaco:
• Non temere gli Dèi.
• Non temere la morte.
• Il bene è facile da ottenere.
• Il male è facile da sopportare.Analizzando questi punti, andando oltre la formale apparenza, lo spaccato che ne deriva è un insegnamento molto profondo, valido in ogni epoca e luogo.
Per garantirsi una vita felice, l’uomo dovrebbe soddisfare solo i desideri naturali e necessari. Questo implica che egli lavori su sé stesso, al fine di rimuovere le stratificazione dovute ai “luoghi comuni“, che lo inganna e lo imprigiona; come ad esempio la riprova sociale.
A tale scopo, necessita di una “Stella Polare“, la quale non può essere un’autorità, spesso priva di autorevolezza. É l’autorevolezza a dare luogo all’autorità, proprio come un fiore diffonde la fragranza. Quando l’autorità assume carattere impositivo perde l’autorevolezza. Non è il profumo a creare il fiore. Come conseguenza, la consapevolezza trasla dalla Luce all’ombra.
L’ombra, l’ignoranza, è figlia dell’ostacolo. Per rimuoverlo, un mezzo efficace, è l’auto-indagine, il guardarsi dentro. L’uomo deve interrogarsi profondamente sul perché ha paura degli Dèi, (l’oggetto della paura), e scoprire se in verità teme maggiormente i Loro “amministratori” (i creatori della paura).
Nella via spirituale la disciplina è l’autorità che, senza coercizione, instrada il praticante verso l’essenza, dall’ombra alla Luce. In tale tragitto, uno stadio fondamentale è il “filosofo-re“, l’autorevole che, attraverso la saggezza e la virtù non imposta, ispira e guida gli altri: servizio altruistico.